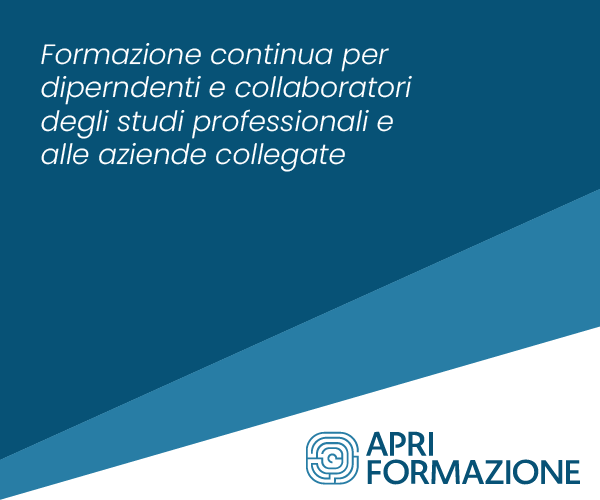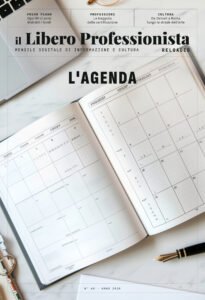Che la sostenibilità sia una materia ostica lo intuisce abbastanza rapidamente chi si avvicina per cercare di capirci qualcosa: è costellata di acronimi e termini che si assomigliano, propone un modo di ragionare a cui imprese e professionisti non sono abituati, non c’è un unico standard di riferimento e, dal punto di vista della comunicazione, alterna scenari catastrofici a messaggi di apertura e speranza in cui tutti insieme – e anche singolarmente – si può (ancora) fare la differenza.
Proviamo quindi a fare un po’ di ordine e chiarire almeno i termini più ricorrenti che spesso vengono confusi a cominciare proprio dalla differenza tra sostenibilità ed Esg, che sembrano ormai essere usati in modo alternativo ma che invece sottintendono argomenti diversi.
(foto Gro Brundtland)
Il Rapporto Brundtland
Per comprendere che cosa si intende per sostenibilità è indispensabile risalire al Rapporto “Our common future” (Il futuro di tutti noi), meglio conosciuto come Rapporto Brundtland, dalla presidente della Commissione mondiale su Ambiente e Sviluppo (World Commission on Environment and Development, WCED), Gro Brundtland, che lo presentò nel 1987. In quel documento si evidenzia per la prima volta la necessità di attuare una strategia in grado di integrare le esigenze di sviluppo con quelle legate alla salvaguardia dell’ambiente. Questa strategia è stata definita “sustainable development” (sviluppo sostenibile) intendendo con esso «quello sviluppo che consente alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri».
La sostenibilità, dunque, comprende tutti quei comportamenti che un’impresa – e altrettanto uno studio professionale – mette in atto per ridurre il suo impatto e fare in modo che le risorse che utilizza non compromettano quelle a disposizione delle future generazioni. La sostenibilità chiede alle organizzazioni di creare nuovi modelli di business, di rivedere i propri processi di produzione e/o erogazione di servizi e, in generale, di ripensare tutti quei comportamenti che generano un impatto non solo sugli azionisti ma sugli stakeholder, una rosa di portatori di interesse ben più ampia.
Ancora, la sostenibilità chiede di modificare il paradigma spazio-temporale secondo cui queste realtà hanno finora ragionato, ossia di ripensare la propria condotta alla luce di una responsabilità che si estende oltre l’utilizzo del bene prodotto o del servizio erogato e di valutarla nel tempo senza limitarsi al breve (brevissimo) periodo imposto dalla rendicontazione di bilancio ma considerandone gli impatti nel lungo periodo, quando sarà possibile valutarne i reali effetti.
(foto ESG)
Tre dimensioni
Che cosa si intende invece con Esg? L’acronimo sta per Environmental (ambiente), Social (sociale) e Governance, ossia le tre dimensioni tra loro correlate usate per rendicontare la sostenibilità e quindi per verificare, misurare, controllare e sostenere l’impegno di un’organizzazione – impresa o studio che sia – in termini di sostenibilità. Ognuna di queste dimensioni E S G è ampiamente articolata e deve essere rendicontata in un report di sostenibilità secondo uno standard: quelli ad oggi più utilizzati sono i Gri – Global reporting initiative, un ente internazionale senza scopo di lucro nato con il fine di definire gli standard di rendicontazione della performance sostenibile di aziende e organizzazioni di qualunque dimensione, appartenenti a qualsiasi settore e paese del mondo”.
Anche l’Europa però si sta muovendo (altri acronimi in arrivo): l’Efrag -European Financial Reporting Advisory Group, il consulente tecnico della Commissione europea per lo sviluppo dei cosiddetti Esrs (European Sustainability Reporting Standards) ha consegnato lo scorso novembre una prima serie di bozze di standard Esg per aiutare le imprese nell’integrazione della Csdr (Corporate Sustainability Reporting Standard Directive), la nuova normativa Ue in materia di rendicontazione della sostenibilità, approvata a fine anno, e che verrà applicata – secondo un piano volto ad ampliare progressivamente le imprese obbligate – a partire dal primo gennaio 2024.
(foto goals)
I 17 obiettivi
Che cosa sono invece gli Sdgs? I “Sustainable Development Goals” sono i 17 obiettivi – tra loro interconnessi – contenuti nella Agenda 2030, la risoluzione approvata il 25 settembre 2015 dai 193 Stati membri dell’Onu. I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile – a loro volta articolati in 169 punti – mirano ad affrontare un’ampia gamma di questioni relative allo sviluppo economico e sociale, che includono la povertà, la fame, il diritto alla salute e all’istruzione, l’accesso all’acqua e all’energia, il lavoro, la crescita economica inclusiva e sostenibile, il cambiamento climatico e la tutela dell’ambiente, l’urbanizzazione, i modelli di produzione e consumo, l’uguaglianza sociale e di genere, la giustizia e la pace.
Benefit differenti
Andando ancora avanti sui temi che generano confusione, merita di essere precisata anche la differenza tra società benefit, benefit corporation e Società B-Corp (o semplicemente B-Corp). I termini si assomigliano ma ancora una volta le differenze sono concrete così come le implicazioni che sottendono.
È senza dubbio la parola “benefit” e generare confusione non ultimo perché la traduzione di società benefit (SB) in inglese è “benefit corporation”. Ma attenzione: le società benefit (SB), introdotte dalla Legge di Stabilità del 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (commi 376-383 e allegati 4 – 5) entrata in vigore dal primo Gennaio 2016), sono una particolare forma giuridica legalmente riconosciuta che un’azienda appartenente a qualsiasi settore industriale o merceologico può assumere. Non è un nuovo tipo sociale: qualsiasi società di persone e di capitali, sia esistente o di nuova costituzione, può infatti essere una società benefit.
Le società benefit si distinguono dalle società di capitali ordinarie per il fatto che perseguono, congiuntamente ad una attività economica a scopo di lucro, “una o più finalità di beneficio comune”. Le società benefit sono a tutti gli effetti delle società profit che hanno però un doppio obiettivo:
- realizzare attività lucrative dirette a distribuire utili ai soci
- perseguire iniziative benefiche a favore di una vasta pluralità di portatori di interesse.
(foto b corp)
Altro punto fondamentale da sottolineare è che le società benefit sono tali per così dire per Dna (e non perché hanno ottenuto una qualifica o una certificazione), nel senso che le finalità di beneficio comune sono indicate nello statuto accanto all’attività propria dell’impresa: la valutazione degli impatti generati con il perseguimento delle finalità di beneficio comune è oggetto di una relazione che viene presentata annualmente con il bilancio. Ultimo punto importante: la società può introdurre nella propria denominazione le parole “società benefit” o l’abbreviazione “SB”, e può utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso i terzi facendo così apprezzare il proprio status al mercato e a tutti i suoi interlocutori.
Le società B Corp, invece, sono quelle imprese che hanno ottenuto una qualifica a seguito di una certificazione rilasciata da B Lab – un ente non-profit americano – attraverso la misurazione di alcune performance.
Le società B-Corp si sono sviluppate nell’ordinamento americano come risultato di un movimento imprenditoriale che ha coinvolto un gran numero di imprese interessate al perseguimento del profitto nel rispetto dei più elevati standard di trasparenza e performance di qualità socio-ambientale. Le B-Corp sono imprese profit che decidono volontariamente di sottoporsi a un percorso di valutazione (BIA – Benefit Impact Assesment) per misurare la qualità dell’impatto generato sugli stakeholders: chi riesce ad ottenere un punteggio finale maggiore o uguale a 80 (su 200) può chiedere la certificazione. Attenzione però: la certificazione è valida per tre anni, periodo dopo il quale, se la società lo ritiene, deve essere eventualmente rinnovata. La tariffa annuale per la certificazione B Corp varia tra 500 e 50 mila euro, in base al fatturato annuale dell’azienda.