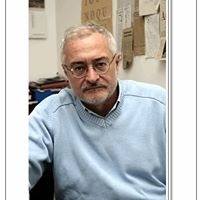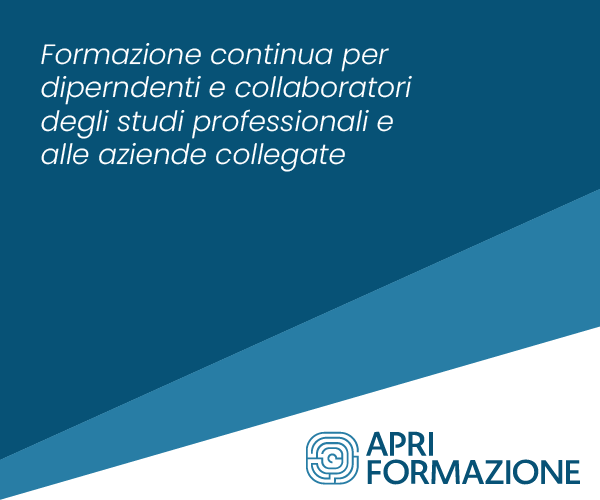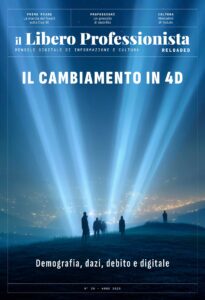Cresce l’occupazione, ma produttività e salari restano al palo. Al crescere dell’occupazione corrisponde un aumento sostanzioso dell’indice di inattività. E anche la retribuzione media in termini di potere d’acquisto ha perso l’8,3%. Un fenomeno che spinge migliaia di giovani a emigrare all’estero.
Il quadro delle politiche del lavoro in Italia presenta alcune particolarità piuttosto insolite rispetto alla dottrina classica: il tasso di occupazione sale costantemente dal dopo covid, superando il 60%, con una forte crescita dei contratti “stabili” che crescono a discapito dei contratti a termine, a testimoniare di una crescita che le aziende giudicano robusta e non occasionale. Tuttavia altri indicatori vanno in direzioni ben diverse: la produzione industriale scende senza clamori ma costantemente dal 2023.
Al crescere dell’occupazione corrisponde un aumento sostanzioso dell’indice di inattività (ossia delle persone che non cercano lavoro- quindi non disoccupati- e non sono comunque disposte a lavorare): si tratta del 33% di quelle in età da lavoro. Tra gli occupati e gli inattivi, i “disoccupati”, cioè coloro che cercano attivamente un lavoro, sono il 5,3% della popolazione; un record per l’Italia, che lascia aperta una grossa domanda per il futuro: la crescita simultanea (com’è attualmente), dell’occupazione e dell’inattività finirà per schiacciare la zona cuscinetto della disoccupazione e quindi determinerà un’ingessatura del mercato del lavoro, in cui la domanda eccederà stabilmente l’offerta, i giovani avranno sbocchi occupazionali ristretti e insufficienti e i nuovi accessi all’occupazione saranno prevalentemente quelli determinati dal turn over.
In calo anche il lavoro autonomo
Questo quadro si riferisce al lavoro dipendente, ma anche il lavoro autonomo vive da anni una decrescita costante: fino a 20 anni fa il numero dei lavoratori indipendenti era superiore alle 6 mila unità, mentre ormai è stabilmente attorno ai 5 mila. Un effetto collaterale di questa anomala forma di stagnazione è quello dell’immobilità delle retribuzioni, che spesso e volentieri si trasforma addirittura in perdita in termini reali: dal 2008 (quindi passando per due crisi importanti come quella finanziaria internazionale e quella del Covid), la retribuzione media in termini di potere d’acquisto ha perso l’8,3%, mentre, per esempio, quella francese è aumentata del 3,5% e quella tedesca del 5%.
Fenomeno questo che spiega l’insolito quadro in cui, nonostante sia stata alta la domanda di forza lavoro qualificata negli ultimi anni, decine di migliaia di giovani per lo più con alta formazione siano emigrati dall’Italia verso altri Paesi: 156 mila nel 2024 e, calcolando a partire dal 2013, oltre 500 mila.
Questa dinamica esercita un ruolo importante nel ritardo tecnologico che connota i nostri settori produttivi, soprattutto sul terreno dell’informatica e delle sue applicazioni più avanzate, che di solito sono veicolate dai giovani con alti profili di formazione.
Produttività in frenata
E, seguendo la catena del sistema produttivo, arriviamo a quello che sta alla base della situazione vista sopra: la produttività. Un primo dato, di carattere generale ma che sottende efficacemente quello sulla produttività, e quello relativo al Pil: dal 1990 ad oggi il prodotto interno lordo italiano è cresciuto di 19 punti, contro 46 della media europea.
La produttività è comunemente definita come il rapporto tra il volume dell’output e degli input che concorrono alla sua realizzazione. Essa misura l’efficienza dell’impiego nel processo di produzione dei fattori primari, lavoro e capitale ed è considerata un indicatore chiave di crescita. L’approccio utilizzato dall’Istat per stimarla consente di scomporre la dinamica dell’output nei contributi derivanti dai fattori produttivi primari (lavoro e capitale) e dalla PTFi. (produttività totale dei fattori). La produttività del lavoro è data dal rapporto tra valore aggiunto e ore lavorate; la produttività del capitale è misurata dal rapporto tra valore aggiunto e input di capitale.È interessante vedere come l’andamento di questi indicatori impatti sull’economia reale. Nel caso della produttività del lavoro è opportuno ricordare che essa è misurata dal rapporto tra ore lavorate e valore aggiunto della produzione, pertanto l’aumento dell’occupazione negli anni successivi al Covid e un aumento del valore aggiunto inferiore a quello delle ore lavorate ha determinato un calo della produttività: rispettivamente +2,7% e + 0,5% nel2023, pari a un rapporto di 2,5 punti inferiore a quelli degli ultimi anni.
Questa insolita dinamica spiega in gran parte il paradosso italiano, per cui all’aumento dell’occupazione corrisponde una quasi stagnazione delle attività produttive e delle retribuzioni: l’andamento delle retribuzioni segue quello della produttività, e se un sistema produttivo non è in grado (o non vuole) aumentare alcuni fattori (l’input di capitale nel nostro caso e soprattutto di ricerca e innovazione) il solo input di ore lavorate non consente una crescita della produttività significativa, e la competitività del sistema resterà determinata dalla competitività sui costi dei fattori e quindi, in un sistema come il nostro ad alta intensità di mano d’opera, sulle retribuzioni. In sostanza, come del resto suggeriscono altri indicatori (la spesa per R&S in Italia è pari al 1,5% del Pil, mentre la media Ue è 2,3%), quanto a competitività del nostro sistema produttivo resta prevalentemente dipendente dai bassi costi permessi dai bassi salari, come per i Paesi in via di sviluppo.