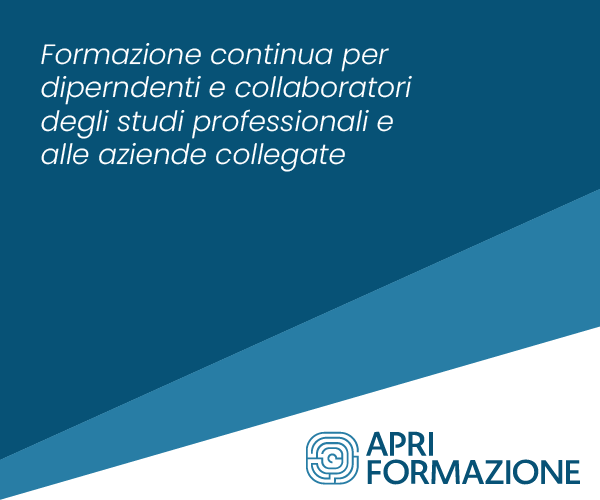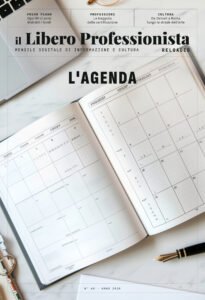Nato nel 2021 con 30 miliardi in dotazione destinati a finanziare 30 interventi a sostegno del Pnrr, il Piano Nazionale Complementare è in grave ritardo sulla tabella di marcia. Lo scorso settembre è stato raggiunto solo il 55% degli obiettivi del trimestre e il 27% di quelli complessivi con scadenza 2026. E ora, dopo essere stato alleggerito di 4 miliardi, il raggiungimento dei target previsti diventa una priorità.
Esiste da tre anni eppure sembra essere caduto nel dimenticatoio. Il Piano Nazionale Complementare (Pnc), approvato nel 2021 con 30 miliardi in dotazione per finanziare 30 interventi a sostegno del Pnrr, infatti, non è riuscito ad accendere l’interesse nell’opinione pubblica. Del resto, mancando il controllo europeo sul cronoprogramma (che è strutturato, come quello del PNRR, su target intermedi e finali), la sua attuazione è stata affrontata – per usare un eufemismo – con maggiore tranquillità. Ma forse si è un po’ esagerato se è vero, come rilevato dalla Ragioneria generale dello Stato, che il Piano versa in una situazione di grave ritardo. Più precisamente, secondo gli ultimi dati disponibili, a settembre 2023 è stato raggiunto solo il 55% degli obiettivi del trimestre e il 27% di quelli complessivi con scadenza 2026. E in queste basse percentuali rientrano anche gli obiettivi conseguiti solo in parte.
Uno scenario che ha convinto il Governo, nel quadro della revisione complessiva del Pnrr, a intervenire anche sul Pnc. Come è noto, il definanziamento da 15 miliardi di euro ha imposto di trovare risorse alternative per coprire i progetti stralciati dal Pnrr perché in ritardo o per altre cause logistiche. Si parla di investimenti sul territorio (i due terzi riguardano i Comuni), di portata molto variabile. Innanzitutto, vi sono ben 44 mila progetti comunali per opere medio-piccole di messa in sicurezza del territorio, adeguamento degli edifici, efficientamento energetico e sistemi di illuminazione pubblica. Vi sono poi progetti di rigenerazione urbana per i Comuni più grandi e, collegati a questi, i Piani Urbani Integrati per la riqualificazione delle periferie metropolitane, come i quartieri Corviale a Roma e Scampia a Napoli.
La notizia che tali investimenti sarebbero usciti dal Pnrr ha condotto a una prevedibile levata di scudi da parte di molti amministratori locali, poi tranquillizzati proprio dall’annuncio del Governo che tutti gli investimenti previsti saranno coperti da fonti di finanziamento alternative (e in parte addirittura reinseriti nel Pnrr con una marcia indietro che ha rappresentato l’effetto più immediato delle polemiche)
PNC taglio da 4 miliardi
Il primo a fare le spese di questi spostamenti di risorse è stato proprio il Piano Complementare, ridimensionato per quasi 4 miliardi di euro. La scelta non stupisce. Infatti, se è vero che il Pnc mobilita somme di molto inferiori rispetto al ‘fratello maggiore’ che vale quasi 200 miliardi, è anche vero che si tratta di risorse già stanziate a bilancio e pronte a essere spese. In altri termini, nella fase attuale i 30 miliardi del Pnc sono fondamentali per allungare la proverbiale coperta. Soprattutto laddove si consideri che l’altro programma di finanziamento alternativo al Pnrr, il Fondo sviluppo e coesione, è uno strumento molto meno flessibile e immediato. Circa 2,5 miliardi vengono comunque recuperati attingendo ad altri fondi, ma da ora in poi il Piano Complementare è sorvegliato speciale. Infatti, il nuovo Decreto-legge 19/2024, che recepisce le modifiche concordate con Bruxelles, attualmente in fase di conversione alla Camera, prevede la verifica semestrale del CIPESS sui costi afferenti alla realizzazione degli investimenti, con definanziamento dell’intervento nel caso in cui venga rilevata l’inosservanza del cronoprogramma.
I motivi dei ritardi
Ma cos’è che non ha funzionato nel Piano Complementare? Analizzandone il contenuto, notiamo innanzitutto che esso contiene un’interessante spinta innovativa. Per esempio, vengono finanziati con un miliardo gli accordi per l’innovazione, vale a dire gli incentivi del Mimit a sostegno delle imprese che investono in ricerca e sviluppo. E in ambito sanitario, un altro miliardo viene stanziato per lo sviluppo di centri e reti di ricerca e trasferimento tecnologico e per la creazione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS). Tutti progetti che sembrano essere positivamente avviati, il che impone di cercare altrove le ragioni dei ritardi.
Andando avanti nella lettura, scopriamo che il vero cuore del Pnc è costituito dagli investimenti infrastrutturali per la mobilità e per lo sviluppo delle aree interne. Ed ecco trovata la spiegazione delle difficoltà attuative: tale focalizzazione sulle infrastrutture ha reso i progetti particolarmente sensibili all’aumento dei costi delle materie prime degli ultimi due anni e a quelle ormai note difficoltà di natura amministrativa nella messa a terra degli investimenti che hanno impattato negativamente anche sul Pnrr. Pensiamo alle nuove linee ferroviarie Roma-Pescara e Palermo-Catania: a fronte dell’impossibilità di realizzare le opere entro il 2026, la prima è stata integralmente stralciata, la seconda fortemente ridimensionata. Migliore è la situazione degli investimenti per ricostruzione post-sisma del Centro Italia a cui sono destinati quasi 2 miliardi (con il programma Next Appennino) e che, non a caso, possono contare su una struttura di supporto amministrativo a livello locale ormai ben consolidata. Risultano conseguiti anche gli obiettivi di riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico, finanziati con altri 2 miliardi. Insomma, tra top e flop degli ultimi tre anni il Piano Nazionale Complementare, pressoché sconosciuto ai non addetti ai lavori, rivela sorprese da scoprire.