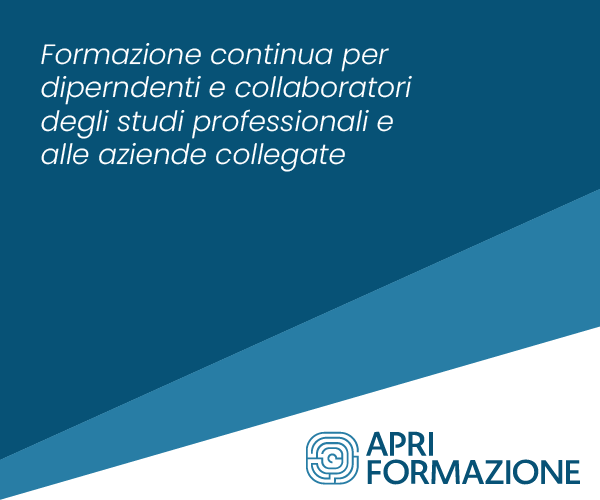La direttiva Ue 2023/970 sulla trasparenza salariale vuole rafforzare l’applicazione del principio della parità retributiva di genere per lo stesso lavoro. Ma il diritto del lavoro da solo non sarà in grado di eliminare una discriminazione che nasce dalla struttura sociale del nostro Paese. Così parlare di parità retributiva per uno “stesso lavoro o per un lavoro di pari valore” senza precisarne i criteri di valutazione è una finzione.
Secondo gli ultimi dati Eurostat, in Italia il gap retributivo medio (ossia la differenza nella retribuzione oraria lorda tra uomini e donne) è pari al 5% (al di sotto della media europea che è del 13%). Invece quello complessivo (ossia la differenza tra il salario annuale medio percepito da donne e uomini) è pari al 43% (al di sopra della media europea, che è pari al 36,2%). Attraverso la direttiva 2023/970, che sancisce per l’ennesima volta la parità retributiva tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore e il divieto di discriminazione in materia di occupazione e impiego per motivi di genere, l’Unione europea intende ora rendere trasparenti le informazioni sui livelli retributivi e sviluppare strumenti o metodologie, che rendano facile valutare e confrontare il valore del lavoro.
Basterà la trasparenza a sconfiggere la discriminazione retributiva? La risposta più attendibile è “no”. Da un punto di vista strettamente normativo, non esiste una regola di parità di trattamento. Il datore di lavoro è libero di retribuire o trattare in modo diseguale i lavoratori purché le differenze siano motivate sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere (come previsto dal considerando 39 della direttiva).
Il variabile in busta paga
Ora si dà il caso che ci siano moltissime ragioni per trattare in modo diseguale uomini e donne a parità di mansioni: le donne se hanno figli o anziani da accudire si assentano di più, sono meno disponibili a trasferte, a trasferimenti geografici, a lavorare nei giorni festivi o di notte o a fare lo straordinario. Sul piano retributivo, i minimi tabellari sono identici per uomini e donne: nessun contratto collettivo si sognerebbe mai, oggi, di diversificare i trattamenti per sesso, anche se in passato è accaduto. Ciò che cambia è la parte variabile della retribuzione, ossia i criteri per l’attribuzione di trattamenti individuali, i cosiddetti ad personam, o le indennità legate a difficoltà o a penosità del lavoro, o a determinati risultati, al titolo di studio o a determinate competenze, l’impegno, la responsabilità. Parlare di parità retributiva per uno “stesso lavoro o per un lavoro di pari valore” senza precisarne i criteri di valutazione (art. 4 dir.) è una finzione; e questo perché l’inquadramento e la retribuzione possono essere determinati tenendo conto anche di elementi diversi dal mero tempo di lavoro o dall’anzianità di servizio. Fattori oggettivi e neutri come, ad esempio, il titolo di studio, la disponibilità alla mobilità geografica, le dimensioni dell’unità produttiva, le competenze/qualifiche possono giustificare le differenze.
Uguaglianza formale
Quindi è assai probabile che i gap retributivi e di carriera continuino a manifestarsi nonostante il rafforzamento della normativa antidiscriminatoria, perché l’eguaglianza di opportunità sostanziale è cosa ben diversa dall’eguaglianza formale: la prima può avere effetti perfino superiori rispetto alla seconda, ma richiede seri investimenti pubblici per la correzione o la rimozione delle troppe diseguaglianze di partenza cui abbiamo fatto cenno, molte delle quali non sono credibilmente eliminabili. Ma questo è un problema che la direttiva non affronta.
Il peso della maternità
Secondo l’Ufficio studi della Camera nel 2022 abbiamo registrato il tasso più basso di donne occupate tra gli stati dell’Ue: solo la metà della forza lavoro femminile di età compresa tra i 20 e i 64 anni. Poi c’è il dato più̀ emblematico che spiega, almeno in parte, l’inverno demografico in cui siamo piombati: nel 2022 una donna su cinque ha detto addio al lavoro dopo la maternità a causa della difficoltà di conciliare le necessità di cura familiare con il lavoro. Un’esigenza, quella della conciliazione, che dovrebbe accomunare madri e padri e che invece resta ancora un problema delle sole lavoratrici. La decisione di lasciare il lavoro è infatti determinata per oltre la metà – il 52% – da esigenze di conciliazione e per il 19% da valutazioni economiche. Ma la vera differenza, per rimanere al lavoro, la fa il titolo di studio: un livello d’istruzione più elevato annulla quasi la differenza tra tassi di occupazione di madri e non madri (il secondo è pari al 91,5% del primo).
La scelta obbligata del part-time
Un esempio di come la discriminazione nasca dalla struttura sociale del nostro paese è costituito dal lavoro a tempo parziale. Per le statistiche il part-time è “involontario” quando un lavoratore accetta un lavoro a orario ridotto in assenza di opportunità di lavoro a tempo pieno. Ma per le lavoratrici madri il part-time quasi mai è – in questo senso – involontario. È formalmente voluto e negoziato da ciascuna di loro perché è una scelta obbligata, determinata dalla necessità di conciliare i tempi di lavoro con i tempi di cura. Per questo motivo in Italia si registra la netta prevalenza del part-time femminile, che riguarda poco meno del 49% delle donne occupate contro il 26,2% degli uomini, con inevitabili conseguenze sul divario retributivo e previdenziale di genere. Nessuno può imputare questo esito a discriminazione operata dal datore di lavoro che si limiti ad accogliere le richieste di riduzione dell’orario di lavoro di una lavoratrice con figli piccoli rispetto al collega assunto a tempo pieno; o a gratificare con maggiorazioni economiche il collega con orario full time, con o senza figli piccoli, che accetti una trasferta o un trasferimento in una zona lontana dalla abitazione familiare. La discriminazione tuttavia c’è, eccome, e sta “nell’equilibrio mediterraneo” che governa la distribuzione degli oneri di cura tra i due generi e che sfugge a tutti i divieti e a tutte le misure tese a combattere le differenziazioni attraverso la trasparenza. E non sarà il diritto del lavoro a sradicarla.