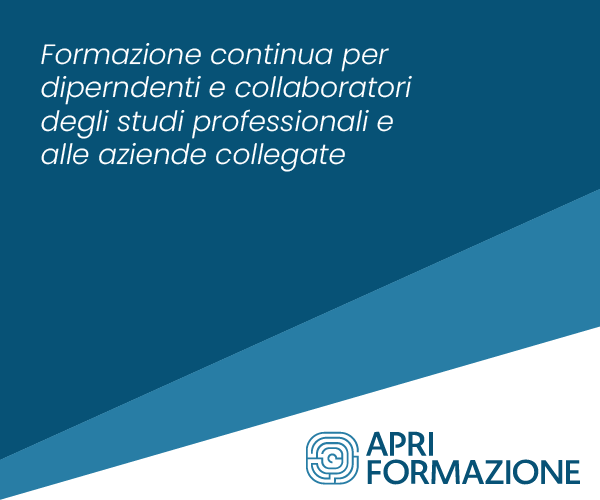È una forma di pressione e vessazione sempre più diffusa negli ambienti di lavoro italiani. Spesso è l’anticamera del mobbing, ma ha caratteristiche e conseguenze proprie, con impatti profondi sul benessere del lavoratore e sul clima aziendale.
La nuova frontiera della violenza psicologica sul lavoro si chiama straining. È molto più comune di quanto si creda e va ad aggiungersi a fenomeni più conosciuti, come lo stalking e il mobbing, che descrivono forme diverse di vessazione, umiliazione e persecuzione delle quali, secondo le stime, oltre un milione e mezzo di lavoratori è stato vittima almeno una volta nella propria carriera lavorativa. Sebbene lo straining sia spesso l’anticamera del mobbing, per la giurisprudenza rappresenta una categoria a sé. Come si riconosce? E come si combatte?
Se non ci sono gli estremi per il mobbing, forse è straining
Straining deriva dal verbo inglese to strain e vuol dire “mettere sotto pressione”. «È un fenomeno specifico, con una propria valenza psicologica e giuridica» spiega Tiziana Ramaci, psicologa e Ordinario di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni presso l’Università degli Studi di Catania. «Il ricercatore Harald Ege, il primo a occuparsene, ha identificato con questo termine i conflitti organizzativi che, pur non potendo essere classificati come mobbing, comprendono situazioni lavorative ingiuste, stressanti e lesive. Per esempio l’isolamento professionale, la dequalificazione o l’abuso di trasferimenti».
La principale differenza rispetto al mobbing è la modalità con cui viene messo in atto il sopruso. «Nel mobbing, le condotte ostili sono continue e sistematiche, mosse da un intento persecutorio; nello straining, invece, le azioni possono essere anche isolate, ma producono effetti permanenti e profondi sul lavoratore».
Le ripercussioni personali e collettive
Può essere definito come straining, per esempio, un demansionamento che non è giustificato da una mancanza di competenze oppure un trasferimento che non trova ragione in esigenze lavorative oggettive e dimostrabili, ma anche una sola critica pesante che però influisce sulla reputazione.
«Queste condotte possono generare nel tempo un grave disagio psicologico, minando la dignità personale e la fiducia nelle proprie capacità» spiega l’esperta. «Le conseguenze non si limitano alla sfera individuale: anche il clima aziendale ne risente, con ripercussioni sulla produttività e sulla coesione del gruppo di lavoro».
Secondo la sentenza numero 3291 della Cassazione civile, perché si possa parlare di straining devono sussistere alcuni parametri: ci si trova in un ambiente di lavoro, la vessazione si verifica anche solo una volta ma ha conseguenze sistematiche per almeno sei mesi, le azioni che innescano il disagio sono palesemente ostili, la vittima è cosciente della sua posizione di inferiorità rispetto al suo “carnefice”, e l’obiettivo è evidentemente discriminatorio.
Il difficile riconoscimento giuridico e la prevenzione
Come accade spesso nell’ambito della sfera psicologica, il riconoscimento giuridico dello straining non è semplice. «Bisogna dimostrare il nesso tra le azioni subite e il danno alla salute, ma anche la prova del comportamento illegittimo del datore di lavoro» dice Ramaci. «Alla prova dei fatti, la domanda giudiziale del lavoratore viene spesso rigettata, soprattutto per la difficoltà di dimostrare il collegamento funzionale fra i singoli episodi vessatori e il loro intento persecutorio».
Per questo motivo, la strada più efficace resta la prevenzione: promuovere ambienti di lavoro sani e rispettosi, investire nella formazione e potenziare i servizi di supporto psicologico. Se ne è parlato, per esempio, nel recente webinar “Mobbing e Straining: gli strumenti di tutela per i professionisti sanitari”, dedicato da Club Professioni Sanitarie ai lavoratori sanitari, tra i quali il fenomeno è particolarmente diffuso a causa di carichi di lavoro eccessivi e rapporti gerarchici spesso molto tesi.